Una discussione tra gli ex ministri Treu e Tridico
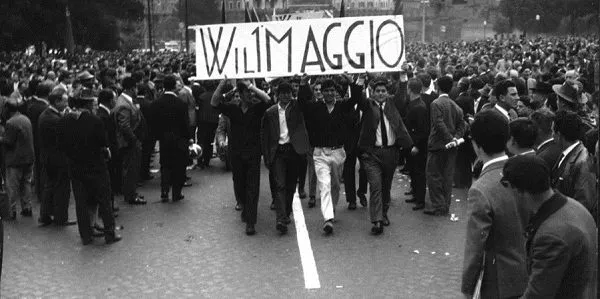
Che effetto hanno avuto le numerose riforme del mercato del lavoro che si sono susseguite in Italia a partire dagli anni ’90? Volendo semplificare molto questa è la domanda che si poneva la discussione promossa dalla Classe di Scienze Politiche e sociali della Scuola Normale Superiore cui hanno partecipato l’ex Ministro del Lavoro, presidente del Cnel, il giuslavorista Tiziano Treu e il parlamentare europeo, già presidente dell’Inps, l’economista Pasquale Tridico, coordinati dal preside della classe Guglielmo Meardi.
A fare da sfondo alla discussione un mercato del lavoro che nonostante le molte riforme non ha conosciuto rivoluzioni in termini quantitativi: negli ultimi anni è infatti aumentato il numero di occupati ma è diminuito il monte ore lavorato. Non solo, i dati sulla cresciuta partecipazione (il numero di persone attive sul mercato del lavoro), ha segnalato Meardi, è anche figlio dell’inverno demografico: meno persone in assoluto sono in età da lavoro. Degli oltre 18 milioni di lavoratori dipendenti un terzo, circa sei milioni, ha un contratto a tempo determinato o part-time in prevalenza involontario. Giovani e donne sono i più penalizzati: tra i lavoratori sotto i 34 anni, il 35% ha un contratto a tempo determinato, contro il 12% di quelli tra i 35 e i 49 anni, e il 7% di questi oltre i 50 anni. Il numero di donne con lavori part time è salito da 1,6 milioni nel 2004 a 2,7 milioni nel 2019, per poi stabilizzarsi, per gli uomini è salito dai circa 400 mila nel 2004 ai circa 900 mila nel 2019, con lievi oscillazioni negli anni successivi.
Il video completo dell’incontro
I due esperti che pure hanno ricoperto o ricoprono ruoli di responsabilità politica si sono confrontati su tre assi proposti da Meardi: flessibilità, sicurezza e salario. La prima domanda riguarda la mancata relazione tra aumento della flessibilità e occupazione e produttività. L’idea ripresa dal modello di flexicurity dei paesi scandinavi di creare un mercato flessibile accompagnato dalla certezza del reddito (sussidi) e politiche attive del lavoro ha funzionato? I numeri ci dicono di no.
Tiziano Treu spiega la svolta dei ’90 con il clima politico di quegli anni: la flexicurity alla danese era un tentativo di tenere assieme una spinta alla deregolamentazione sostenuta dall’OCSE e un approccio più accorto in termini di tutele del lavoro dell’International Labour Organization. La verità è che in Italia “L’applicazione di questa idea è apparsa come piuttosto complicata, era più facile flessibilizzare che non garantire la sicurezza” ha spiegato Treu parlando degli interventi legislativi implementati quando ricopriva l’incarico di ministro, “la flessibilità rimaneva piuttosto regolata ma doveva essere sostenuta da politiche della formazione e questo non è avvenuto”. “Negli anni 90 eravamo il mercato del lavoro più rigido e il nostro fu un tentativo di introdurre flessibilità regolata (poi venne una ulteriore deregolamentazione con i governi Berlusconi) – ha aggiunto Treu – Ma mancava e manca l’idea che le spese per la formazione siano cruciali e siano anche strumenti di welfare”.
L’Italia non ha servizi all’impiego efficaci e un sistema di ammortizzatori squilibrato, ha aggiunto l’ex ministro ricordando come la cassa integrazione, nata come strumento di transizione sia spesso usata come garanzia di reddito per anni. A questo proposito, Tridico ha segnalato come in alcuni casi quello della cassa integrazione abbia avuto funzione di reddito di cittadinanza non dichiarato, nel senso che paga un sussidio a lavoratori che non torneranno in fabbrica per molti anni (a Termini Imerese sono 13 anni). “Servirebbe più flessibilità interna alle imprese, capacità di attrezzare i lavoratori alle nuove domande e a mansioni che cambiano piuttosto che rendere più facile la loro espulsione” ha aggiunto Treu segnalando come oggi “siamo di fronte a trasformazioni epocali che faranno sparire interi settori e professioni”. Servirebbero dunque istituzioni capaci di traghettare le persone da un mondo del lavoro a un altro, accompagnate da politiche industriali e di welfare. Le istituzioni nazionali non appaiono in grado di gestire questa enorme partita e l’Italia in questo senso appare meno attrezzata, con un sistema di ammortizzatori sociali che l’ex ministro del Lavoro definisce un guazzabuglio e la (poca) formazione professionale pensata soprattutto per i disoccupati.
Un problema sul quale sia Tridico che Treu concordano è lo strabismo istituzionale per cui la politica economica e monetaria sono in larga parte o del tutto di competenza europea mentre il welfare e le politiche del lavoro rimangono di competenza nazionale.
Se Treu è critico con alcune delle scelte fatte in passato, Tridico è più netto: se gli obiettivi delle riforme erano l’aumento del tasso di occupazione, la produttività e la volontà di incentivare gli investimenti, le misure introdotte non hanno avuto effetti positivi.
La ragione, sostiene Tridico, è che produttività e flessibilità non sono in relazione. E così la dinamica è quella per cui aumenta l’occupazione in settori a bassa produttività e che non richiedono professionalità avanzate, Tridico chiama questa dinamica “economia da bar”: servizi che impiegano molta manodopera flessibile, pochi investimenti, poca innovazione, competitività basata sul costo del lavoro.
La domanda successiva posta da Meardi riguarda la sicurezza (non sul, ma del lavoro). Davvero siamo andati verso il workfare (ossia un welfare capace di sostenere economicamente e reindirizzare verso il mercato del lavoro) che immaginavamo 20 anni fa? La risposta dell’ex presidente dell’Inps è che prima dell’introduzione del Reddito di inclusione (sottodimensionato) nel 2018 e del Reddito di cittadinanza nel 2019 l’Italia non aveva davvero intrapreso la strada della flexicurity. Interventi successivi sono serviti a garantire forme di reddito a categorie quali gli autonomi o i lavoratori dello spettacolo e altre figure che non avevano accesso a strumenti di tutela del reddito e la riforma della Cassa integrazione ha esteso lo strumento a tutti i lavoratori dipendenti.
Oltre a tornare sulla discussione e sulle politiche degli anni ’90, l’ex ministro del Lavoro ha segnalato l’errore di un sistema di welfare troppo concentrato sui trasferimenti monetari e poco orientato a fornire servizi. Più facile trasferire soldi, paga in termini di consenso immediato mentre investire in creazione di servizi produce effetti in tempi medi.
Terza grande questione riguarda i salari, che in Italia segnano il passo. Treu segnala la differenza tra la fase in cui l’Italia navigava in un’economia mondiale meno aperta e quella successiva alla liberalizzazione totale die mercati internazionali e ai salti tecnologici di questi anni. Oggi i divari, anche all’interno dello stesso mercato del lavoro nazionale sono molto grandi (alcuni contratti nazionali appena firmati recuperano le perdite subite con l’inflazione) ma una fascia crescente di lavoro è esclusa dalla contrattazione collettiva.
Per questa ragione, secondo Treu, il salario minimo pur non essendo la soluzione “potrebbe servire almeno in parte a garantire una qualità minima a quelle fasce povere del lavoro. Che faccia male alla struttura produttiva è una sciocchezza contradetta dalle dinamiche di molti paesi”. Treu si dice incredulo della scelta dei sindacati di essere contrari (o esserlo stati fino a ieri, come la Cgil).
A parere di Tridico i salari non sono cresciuti perché l’aumento della flessibilità ha fatto crescere la precarietà e indebolito i sindacati, togliendo loro potere contrattuale. Negli ultimi anni l’80% dei lavoratori ha avuto incrementi minimi o nessuno, una cosa particolarmente vera per quei settori dei servizi poco qualificati che purtroppo sono anche quelli nei quali cresce l’occupazione. Anche Tridico si dice favorevole (con più convinzione del suo interlocutore) al salario minimo.
La platea ha poi posto la questione dei referendum dell’8 e 9 giugno. A rispondere per primo è l’ex ministro del Lavoro, che spiega come secondo lui la ripresa della discussione sul lavoro può essere utile, con il rischio che in caso di mancato raggiungimento del quorum sia il tema lavoro che quello cittadinanza finiscano nel dimenticatoio. “Sul merito ho una posizione articolata: quello sulla cittadinanza è cruciale”. In materia di licenziamento Treu sostiene che sebbene il quesito venga presentato come un referendum contro la precarietà, l’articolato sul quale interviene è già stato parzialmente modificato dalla corte costituzionale.
Il punto di vista di Tridico è diverso e favorevole ai quesiti: lo strumento servirebbe a costringere il legislatore a intervenire, a occuparsi di temi che sono centrali. Tridico parla del referendum sugli appalti usando l’esempio della tragedia alla Esselunga nella quale hanno perso la vita cinque operai. “Su quel cantiere lavoravano 62 imprese. “Certo c’è un tema di eventuali abusi giuridici ma nel momento in cui hai 62 imprese che lavorano nello stesso luogo i controlli da parte della ditta che vince l’appalto sono impossibili. C’è anche un tema di circolazione delle informazioni tra imprese che lavorano nello stesso luogo”.
Journal Article - 2025
Journal Article - 2023
Journal Article - 2023
Journal Article - 2023
Journal Article - 2023
Monograph - 2023
Monograph - 2022
Monograph - 2022
Journal Article - 2021
Journal Article - 2021